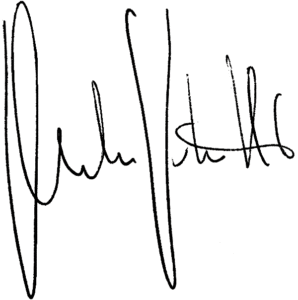Fermi la limousine immediatamente!
disse rivolgendosi all’autista, il quale si trovò, un po’ spaesato a dire il vero, a cercare di manovrare quella lussuosa “nave da strada” in una delle trafficate vie newyorkesi del centro.
Per giunta proprio nell’orario di punta.
Il maestro aveva parlato con un tono deciso eppure cordiale, perentorio persino, ma comunque molto dolce.
Possedeva davvero il dono di un’umanità straordinaria, sapeva come mettere a proprio agio le persone che lo circondavano in ogni situazione; il che non doveva essere esattamente semplice visto l’enorme interesse mediatico che ogni suo spostamento provocava.
Eppure il maestro non perdeva mai la sua bussola interiore: era un esempio di spontaneità, semplicità e spirito di adattamento.
Era come se al termine di ogni sua esibizione, scendesse dal palco non soltanto in senso letterale ma anche in senso metaforico e si mescolasse al resto di noi, come se fosse la cosa più naturale del Mondo.
E dico in senso metaforico perché chiunque, davvero chiunque, conosceva le stupefacenti doti del maestro Pavarotti, uno dei simboli dell’eccellenza italiana, una delle voci più ammirate ed autorevoli di tutto il secolo scorso.
Idolatrarlo era la naturale, logica, conseguenza a tutto questo.
Eppure lui, sfilati i panni del tenore più famoso di tutti, diventava un caro, affabile gentiluomo d’altri tempi: disponibile al dialogo ed auto-ironico.
L’autista fermò la macchina di colpo.
Perchè si sarà voluto fermare?
Io e Alberto ci siamo guardati incuriositi.
Eravamo di ritorno da un incantevole pranzo con il maestro e sua moglie vicino a Central Park, in uno dei luoghi più iconici degli interi Stati Uniti d’America.
Luciano, cedendo alla golosità, chiese di fermare l’automobile perché desiderava ardentemente un gelato al cioccolato.
Piccole debolezze che si concedevano con grande piacere ad un uomo di tale levatura, piccoli dettagli che lo rendevano più umano.

Era il 1996, quell’anno si disputavano i giochi olimpici estivi di Atlanta ed il clima, come sempre in prossimità degli eventi a 5 cerchi, era davvero elettrico.
A quei tempi ero il manager di un’altra leggenda del made in Italy, uno di quei nomi che basta dirlo a voce alta per far aprire a tutti il vasetto dei ricordi: Alberto Tomba.
Chiunque ha un ricordo legato all’Albertone nazionale che scende tra i paletti stretti di qualche pista in giro per il circuito; vederlo sciare univa il Paese come la Nazionale di calcio, era quasi un rito pagano a cui nessun italiano sembrava volersi sottrarre.
Preferibilmente di domenica, in famiglia, e davanti ad una tavola imbandita.
È spontaneo, irruente, capace di bucare lo schermo senza mai essere banale.
Alberto è unico.
A rappresentare l’Emilia Romagna ai giochi americani ci sarebbero stati proprio questi due monumenti tricolori in veste di ambassadors ed io avrei avuto il privilegio di accompagnare Alberto in tutto questo prestigioso percorso.
Non la mia prima Olimpiade.
Non l’ultima.
Ma un ricordo indelebile e fortissimo.

Tutto iniziò con una telefonata: linea rossa, contatto diretto.
Bologna – New York.
Cercavo, dal mio ufficio, di mettermi in contatto con l’entourage del maestro per provare a coordinare e far combaciare le agende di due personaggi tanto impegnati.
Qualcuno rispose con un cordiale inglese ed io, ingenuamente, non mi accorsi immediatamente del suo accento.
Buongiorno, vorrei parlare con il maestro.
sfoggiando il mio, di inglese.
Oh glielo passo subito, visto che ha già la cornetta in mano, e, a proposito, complimenti per la sua pronuncia.
rispose lui, che non resisteva mai alla tentazione di scherzare, sempre cordialmente.
Ed erano proprio questi piccoli dettagli a renderlo magnetico.
Invitò me ed Alberto a raggiungerlo nella Grande Mela, dove aveva in agenda un concerto dei tre tenori, uno dei gruppi più famosi della storia della musica.
Poi da lì saremmo andati ad Atlanta.
Cosa fu quel concerto, non saprei da dove iniziare a raccontarvelo.
Se ne trovano dei filmati online, vi invito ad andare a vederli e vi consiglio di guardare lo stupore negli occhi della folla, l’emozione che sapevano creare quelle tre leggende sul palco.
La location era il Giant Stadium, la colossale arena del football americano ed io non potrò mai dimenticare l’effetto dei 3 che cantano a squarciagola “New York, New York” di Frank Sinatra con davanti agli occhi la skyline più famosa dell’intero pianeta.
Il tutto dalla prima fila.
Io e Alberto eravamo senza fiato.
Nel camerino il maestro ci accolse come se fossimo amici di vecchia data, era tutto molto spartano, ricordo di aver visto una maglia della Juveappesa da qualche parte, una delle sue passioni più grandi.
Comunque devo ammettere che i dialoghi tra Alberto e Luciano sembravano dei duetti tra grandi, affiatatissimi cabarettisti.
Uno forbito, l’altro ruspante.
Uno riflessivo, l’altro istintivo.
Ma entrambi dotati di humor e di un tempo comico davvero coinvolgente.
Mi sono goduto dei dialoghi di superlativa fattura, orchestrati così, a braccio, come nella commedia dell’arte.
Nell’aereo che ci portò ad Atlanta ad esempio, Luciano si addormentò russando pesantemente.
Alberto attirava la mia attenzione e lo imitava, simulando una russata, se così si può dire, fatta con il do di petto.
Dovevo fare del mio meglio per trattenermi e non scoppiare in una risata fragorosa che lo avrebbe svegliato.
Un’altra cosa poco risaputa è che il maestro aveva paura degli atterraggi.
Non del volo in sé quindi ma, complice un’infelice esperienza avuta anni addietro in un volo su Malpensa, proprio degli ultimi instanti prima dello spegnimento nel mezzo.
Per cui quando eravamo in fase discendente ci prese candidamente per mano, come soleva fare con chi viaggiava seduto accanto a lui.
Non ci mollò le mani, come se fossero due tenaglie, fino al completamento della manovra.

Ci godemmo quei Giochi con una leggerezza rara, difficile da avere quando qualche tuo atleta è coinvolto nelle competizioni.
Ricordo l’incredibile silenzio che calò al nostro ingresso a Casa Italia che era, come sempre in queste occasioni, un piccolo gioiello architettonico che diventava centro di gravità permanente di tutta la spedizione azzurra.
Riuscimmo ad assistere ad alcune competizioni, come quando ci infilammo alla partita di volley con le T-shirt verdi, bianche e rosse.
Vedere Alberto confondersi tra la folla, tifare, mostrare patriottismo e sincero trasporto fu una grande lezione di senso di appartenenza.
Le Olimpiadi sono, per me, sempre una grande miscela di emozioni fortissime.
Il tifo si trasforma più che altro in una festa itinerante e continua, dove lo spirito olimpico di fratellanza globale emerge prepotentemente.
Di solito è dopo i Giochi il momento di lavorare sugli atleti per valorizzare i loro risultati, non durante.
E questo mi permette di viverli quasi sempre come un semplice tifoso, anche se privilegiato, visto che ho sempre un posto in prima fila.
L’epopea olimpica è sempre e comunque emozionante.
È come un megafono che amplifica tutto quanto: sia i successi e le imprese sia le delusioni che, fisiologicamente, si possono palesare.
Ai Giochi di Torino del 2006, ad esempio, ho vissuto una delle pagine più surreali e toccanti della mia carriera professionale.
Erano i Giochi di casa per noi, e questo li caricava di un’attesa enorme, anche superiore al già importante carico emotivo che una rassegna del genere porta con sé.
La città si riempì di tifosi provenienti da tutto il Mondo e a livello logistico resse stupendamente l’urto di quella pacifica, festante invasione.
Mi ricordo che l’organizzazione aveva previsto ampi parcheggi piuttosto distanti dai luoghi delle competizioni, predisponendo poi un servizio navetta, molto efficiente in verità, per trasportare tutti nei pressi dell’evento interessato.
Fu proprio su una di quelle navette che ebbi un piccolo assaggio dello spirito olimpico.
Lo spirito olimpico che non fu la sola cosa che assaggiai in quel tragitto ad essere sincero, perché dei chiassosi e allegri tifosi svedesi andavano su e giù per il mezzo ad offrire grappa fatta in casa a tutti quanti.
Questa era l’aria che si respirava.
E quanto ne avevo bisogno in quel momento!
Mi stavo infatti recando a vedere la prova dello slalom, in quella che sarebbe dovuta essere la gara di Giorgio Rocca.
Giorgio era sotto una pressione enorme in quel periodo.
Arrivava da cinque primi posti consecutivi in slalom nella Coppa del Mondo.
Era il favoritissimo.
Correva in casa.
Sarebbe sceso con il primo pettorale, e giù, in fondo al traguardo, un popolo intero lo aspettava per celebrare con lui la vittoria annunciata.
Era molto da gestire.
Moltissimo.
Anche per quello avevamo scelto di non stare all’interno del villaggio olimpico ma di affittare un appartamento dove lui, insieme alla sua famiglia, potesse mantenere un po’ più di privacy, chiuso in un silenzio stampa che lo proteggesse da almeno parte del circo mediatico e non.
33 secondi.
Tanto durò lo sfortunato slalom del nostro campione.
Ricordo solo l’irreale silenzio che calò improvviso su tutta la pista.
Un silenzio quasi sacrilego.
Non sapevo neppure dove guardare.
Non sapevo se volessi oppure no incrociare il suo sguardo.
Era tanto il dispiacere per lui, un campione ed un amico con il quale non potevo fare altro che identificarmi.
Perchè in fin dei conti, forse, sono anche questo le Olimpiadi: l’occasione di avvicinarsi al campione, di identificarsi con il grande viaggio che questi uomini e donne devono fare per arrivare lì.
4 anni ci sacrifici e di lavoro che sublimano o sfumano in una gara che, a volte, può durare anche solo 33 secondi.
Ogni istante è eterno, eppure sempre nuovo, perché ogni 2 anni ci saranno di nuovo quei meravigliosi 5 cerchi affissi da qualche parte, quest’anno è stata la volta della Korea, e con loro anche mille e più storie da vivere e da raccontare.